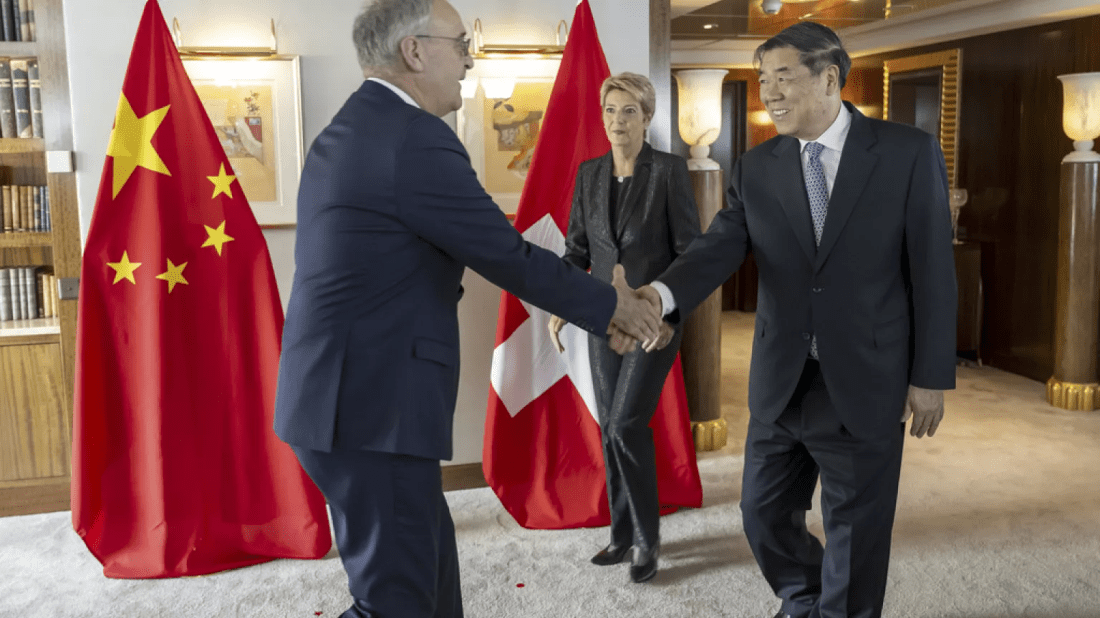Quando si parla di politiche pubbliche non si parte dagli slogan, ma da un’analisi seria. Prima si capisce qual è il problema reale: serve davvero un nuovo programma o possiamo intervenire diversamente? Poi bisogna guardare ai fallimenti del mercato che vogliamo correggere: prezzi troppo alti, poca concorrenza, disuguaglianze. Da lì si aprono le alternative, perché non esiste mai una sola soluzione e ogni opzione ha pro e contro.
Il passo successivo è il disegno del programma: chi ha diritto, con quali criteri, con quali limiti. Sembra un dettaglio tecnico, ma è il cuore della questione. Subito dopo arriva la parte più scomoda: prevedere come reagiranno i cittadini e le imprese. Perché non restano fermi, cambiano comportamento, e spesso in modo imprevisto.
A quel punto si valutano due cose: l’efficienza – se il programma usa bene le risorse o crea sprechi – e la distribuzione, cioè chi ci guadagna e chi ci perde davvero. Qui si tocca il punto più delicato: i trade-off, i compromessi inevitabili fra equità ed efficienza.
Infine servono due condizioni di fondo: chiarezza sugli obiettivi – cosa vogliamo ottenere e perché – e consapevolezza che tutto passa dal processo politico. Senza consenso e senza fiducia, anche la misura più brillante sulla carta rischia di non funzionare.
In breve, fare una politica pubblica significa attraversare un percorso complesso, non scrivere uno slogan.
E veniamo alle iniziative sulle casse malati. L’intenzione è chiara: limitare il peso dei premi cassa malati ai cittadini. Ma se applichiamo i criteri di analisi appena visti, i conti non reggono. Trattiamo quella del 10%.
Già nel primo anno servirebbero circa 300 milioni. Gli iniziativisti sostengono che non tutti chiederanno l’aiuto e quindi il costo sarà minore. Ma un diritto non si calcola sulla speranza che qualcuno non lo eserciti. Lo Stato deve stimare i costi per il 100% dei cittadini. E non basta: i premi aumentano di anno in anno. Quello che oggi costa 300 milioni, nel 2027 potrebbe già diventare 330, poi 350, e così via. Non ci sono analisi di medio periodo, solo calcoli statici sul primo anno.
Anche sul fronte delle entrate i conti non tornano. Un aumento del 10% delle imposte porterebbe circa 150 milioni, ma ne mancano altri 150. Si prova allora a inserire i 40 milioni dell’aumento del valore di stima degli immobili: peccato che quei soldi sono già a bilancio per finanziare scuole, asili e ambiente e la metà appartiene ai Comuni. Cosa facciamo, glieli togliamo? Ultima idea: aumentare l’imposta sulla sostanza dal 2,5 al 3,5 per mille. Ma così si mettono in discussione accordi già votati con la riforma fisco-sociale, con il rischio che le aziende ritirino i contributi che oggi sostengono asili nido e rette delle famiglie.
C’è poi un effetto meno visibile, ma altrettanto importante: se tanto paga lo Stato, i cittadini non avranno più interesse a cercare una cassa meno cara e le casse malati non avranno più incentivo a offrire premi più bassi. Il risultato? Ancora meno concorrenza e una spesa sanitaria destinata a crescere ancora.
Facendo i conti, il deficit del Cantone salirebbe subito oltre il mezzo miliardo già al primo anno. Perché non dimentichiamolo: noi purtroppo non siamo Zugo e i nostri conti sono già oggi sotto di 100 milioni. Poi arriveranno anche i nuovi oneri federali: la riforma EFAS, che vale da sola 200–300 milioni, gli oneri della Confederazione e altre riforme come il valore locativo o la tassazione individuale, che possono pesare altri 150–200 milioni. Totale: quasi un miliardo di buco.
E quando i soldi non ci sono, le strade sono sempre le stesse: aumentare le imposte a tutti, oppure tagliare beni e servizi. E i tagli, come sempre, colpiranno i più fragili: scuole, anziani, sociale, cultura, ambiente. Nessuno resterà escluso.
Fare politiche pubbliche che rischiano di far deragliare le finanze dello Stato non è un gioco. È un esercizio serio, non uno slogan elettorale. Prima servono analisi solide, poi proposte credibili. E allora la domanda è inevitabile: dove sono queste analisi?
Alla fine la scelta è nostra. Ognuno voterà come crede ed è giusto così. Ma bisogna sapere la verità: il conto non sparisce. Non lo pagheremo più nella fattura della cassa malati, lo pagheremo con le imposte, con le rette degli asili, con i tagli ai servizi. Nessun miliardario verrà a salvarci. Alla fine, a pagare, saremo sempre noi cittadini.
Testo in parte pubblicato sui portali