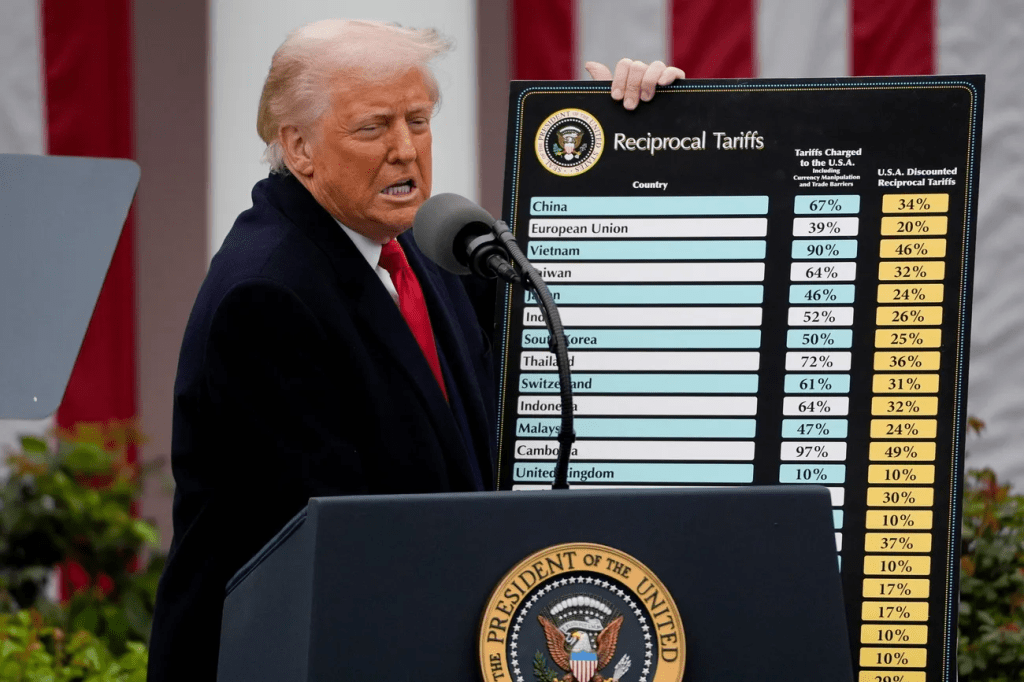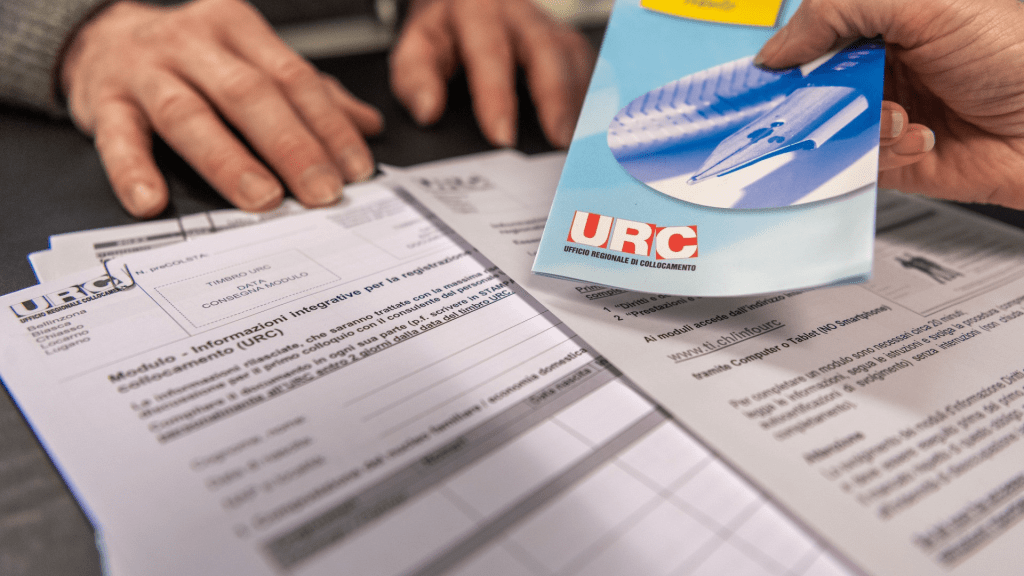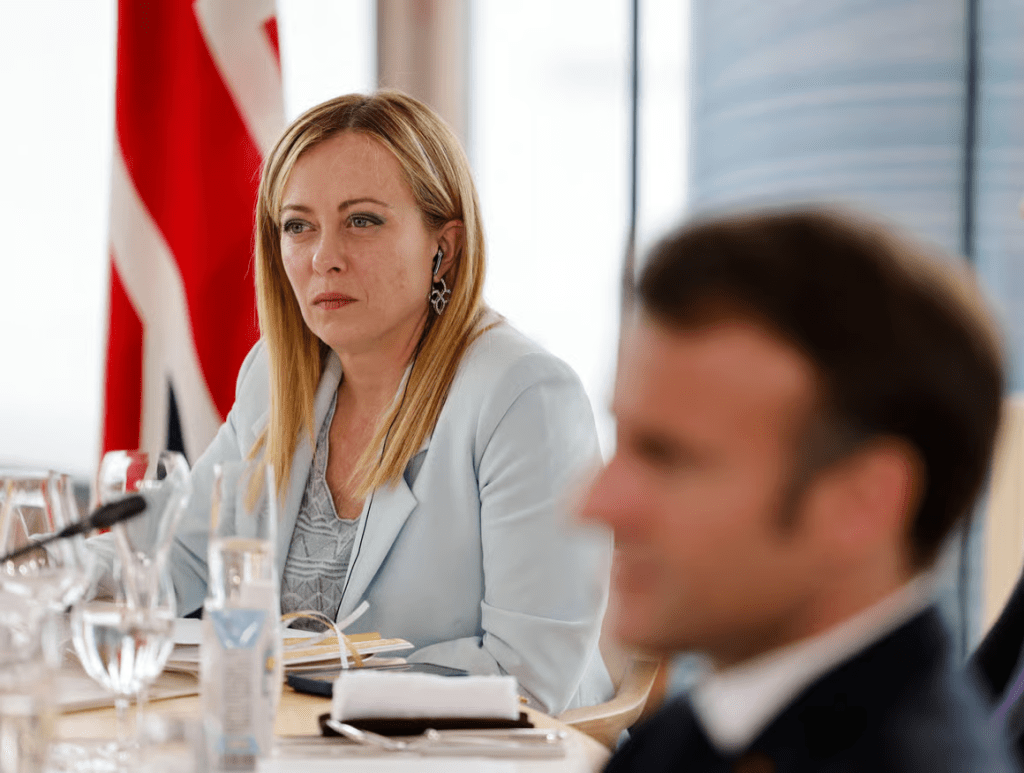Il divario salariale tra Ticino e Svizzera non si riduce, anzi si amplia: nel 2024 aumenta al 18,7%, contro il 17,6% del 2022. Non è un salto brusco, ma conferma una dinamica sfavorevole. Le ragioni sono strutturali. Storicamente il mercato del lavoro ticinese si è sviluppato senza una vera fase industriale e ha puntato su servizi, commercio e turismo, settori con salari mediamente più bassi e più sensibili all’andamento economico. A ciò si aggiunge la posizione di frontiera: ogni giorno entrano circa 80 mila frontalieri che accentuano la concorrenza sui salari e rendono più difficile garantire impieghi stabili e ben retribuiti ai residenti. La struttura occupazionale rimane fragile, con molti posti a basso valore aggiunto e una quota crescente di lavoratori che non raggiunge un reddito sufficiente, tra salari bassi, part-time non desiderati e forte precarietà.
È però importante precisare che, se consideriamo solo i residenti, il divario con la media svizzera scende al 10,7%. La composizione della forza lavoro conta: un terzo dei lavoratori attivi è frontaliero e occupato in settori dove la pressione competitiva è maggiore.
I dati analizzati riguardano oltre 130’000 posti a tempo pieno, equivalenti a quasi 154’000 salariati. Guardando alla distribuzione salariale, il 10% che guadagna meno percepisce 3’710 franchi, il salario mediano (quello che divide a metà la popolazione) è di 5’393 e il 10% più alto arriva a 9’620. I salari crescono, ma non in modo uniforme: si passa dall’aumento dell’1,5% del salario mediano al 3,6% dei salari più alti.
Accanto a questo quadro, alcuni settori registrano una riduzione dei salari rispetto al 2022. Non è ancora una tendenza, ma sono segnali da seguire con attenzione. La costruzione di edifici (circa 5’800 posti a tempo pieno) mostra un calo generalizzato; nell’industria metalmeccanica di base (3’700 impieghi a tempo pieno) la diminuzione riguarda quasi tutte le fasce. Anche il commercio all’ingrosso, un comparto di 10’000 posti, vede riduzioni nelle retribuzioni più basse e più alte. Un andamento simile emerge nei servizi finanziari non assicurativi (3’500 posti) e nelle attività di ricerca e fornitura di personale, dove il calo è quasi ovunque. L’istruzione (oltre 1’300 impieghi) segna una riduzione diffusa mentre nei servizi sanitari, quasi 7’800 posti, la contrazione tocca soprattutto i salari più elevati.
Nel complesso i salari non crollano, ma alcuni settori arretrano. Per il Ticino la vera sfida è restare agganciato al resto della Svizzera. Per questo serve affrontare le cause strutturali del mercato del lavoro e proteggere ciò che funziona, soprattutto in vista di una possibile nuova fase dei rapporti con l’Europa: il Cantone non può permettersi ulteriori slittamenti. I dati non parlano di emergenza, ma indicano con chiarezza la necessità di una rotta solida.
Pubblicato da L’Osservatore, 06.12.2025